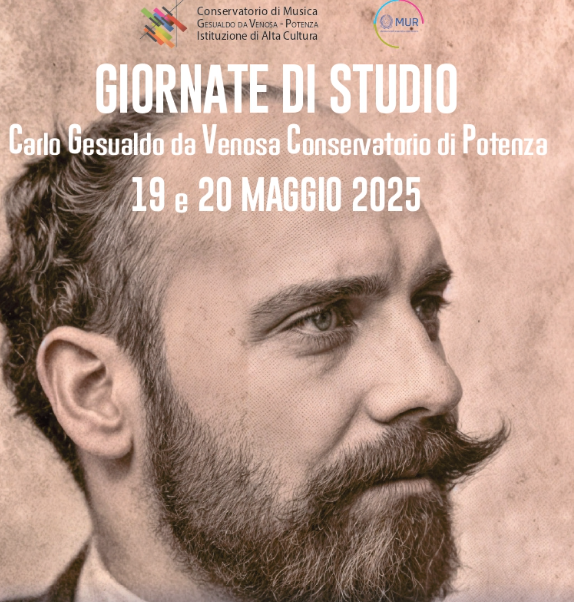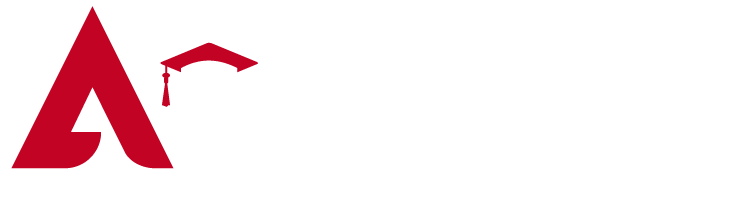Il programma del concerto mette in luce diversi aspetti dell’opera organistica di
Vincenzo Ferroni, tramite l’accostamento a composizioni di suoi didatti al Conservatorio di Parigi e dell’allievo Guido Farina (Pavia, 1903 -1999).
Allo stato attuale delle ricerche la produzione organistica di Ferroni comprende
una quindicina di brani, pubblicati per lo più sul periodico Musica Sacra tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Questa testata diede un notevole impulso
al settore editoriale organistico durante gli anni della “riforma Ceciliana”, che determinò un grande cambiamento nella musica liturgica a partire dalla seconda metà del secolo XIX.
Dopo le derive teatrali della produzione ottocentesca, la riforma propugnava il ritorno all’antica nobiltà di linguaggio del canto gregoriano e della polifonia, sia
nella musica corale che in quella per organo, e conobbe un sensibile impulso tramite il Motu proprio “Inter sollicitudines” del pontefice Pio X (22 novembre 1903).
La maggioranza dei brani organistici di Ferroni è costituita dunque da pagine brevi a destinazione liturgica (due Entrate, tre Elevazioni, tre Versetti, una Sortita, un Postludio, due Preludi); due composizioni (Corale e fuga e Offertorio-Preludio e fuga) si presentano invece di più ampio respiro e sembrano concepite anche per un impiego concertistico, data la maggiore difficoltà tecnica e il frequente uso del Pedale obbligato.
È necessario osservare anzitutto le dediche dei brani, per comprendere il
contesto entro il quale il compositore lucano operò. La dedica a Théodore Dubois
(1837 – 1924) apposta al primo dei due Preludi pubblicati sul periodico Musica
sacra n.5/1891, ci parla della formazione al Conservatoire de musique di Parigi.
Ferroni vi studiò dal 1877 al 1883 con i professori Augustin Savard e Jules Massenet, mentre Dubois – compositore, organista, celebrato autore di trattati di armonia, contrappunto e fuga – vi fu docente dal 1871, divenendone nel 1896 direttore fino al 1905. Altri dedicatari sono illustri esponenti del movimento Ceciliano italiano. I nomi dei maestri veneti Luigi Bottazzo (1845 – 1924) e Oreste Ravanello (1871 – 1938) compaiono nel Postludio op. 47; il Corale e fuga pubblicato in Musica sacra n.8/1891 è dedicato «all’amico M° Giuseppe Terrabugio»: compositore trentino (Fiera di Primiero, 1842 – 1933), allievo di J.G. Rheinberger al Conservatorio di Monaco di Baviera, Terrabugio fu direttore della testata Musica sacra fino al 1924, divenendone poi proprietario. Infine, l’Offertorio-Preludio e fuga op. 26 (in Musica sacra n.4/1903) reca una dedica a Luigi Mapelli, compositore e direttore d’orchestra nativo di Bellinzago Novarese (1855 – 1913), insegnante di armonia e contrappunto al Conservatorio di Milano.
La formazione francese di Ferroni si palesa con evidenza nella cura dell’impianto formale e delle scelte armoniche, sempre raffinate e sapienti. Nella struttura
e nelle inattese svolte cromatiche del Corale e fuga non può sfuggire l’influenza dei Trois Chorals pour Grand Orgue di César Franck (1822 – 1890), modello insuperato per gli organisti-compositori europei tra Ottocento e Novecento.
Anche l’Offertorio, che reca il sottotitolo Preludio e fuga, svela l’influsso francese già in età barocca il termine Offertoire indicava una forma articolata in più episodi comprendenti una sezione contrappuntistica. Dopo il preludio in tempo Adagio, dal carattere dolcemente espressivo, il nostro autore svolge la sua fuga utilizzando come “soggetto”, ovvero tema principale, la scala ascendente di Sol maggiore, in un trattamento complesso e tecnicamente impegnativo per l’esecutore. Questa scrittura ai limiti dell’accademismo forse provocò l’accusa di arido “grammatico”,
rivolta a Ferroni dal critico musicale Alceo Toni in un’acida lettera del 30 gennaio 1924.
Non privi di interesse sono alcuni pezzi più brevi. La contrazione della forma non
impedisce infatti a Ferroni di esprimersi con una notevole cantabilità (l’insegnamento di Massenet!), sostenuta da un’armonia preziosa e mai scontata e da una fine ricerca timbrica.
Il tipo di strumento necessario all’esecuzione dei brani di più ampio respiro, è certamente un organo “riformato”, ispirato ai coevi modelli transalpina. In particolare francesi – dotato di almeno due tastiere e di una pedaliera con
estensione di due ottave e mezza.
Infine, alcune osservazioni sui brani organistici di mio padre Guido Farina, amatissimo allievo di Ferroni al Conservatorio di Milano dal 1921 al 1926
(completò gli studi nel 1927; successivamente assistette il suo maestro durante la malattia fino alla morte, avvenuta a Milano il 10 gennaio 1934, e fu da lui nominato suo esecutore testamentario). L’accostamento dei due autori mette in luce elementi di affinità e aspetti peculiari della personalità di Farina. L’attenzione alla struttura formale e ad una ricerca armonica originale, pur sempre nel contesto tonale, accomuna maestro e discepolo nella fedeltà alla tradizione, al “linguaggio dei padri”. Farina, però, svela una forte attrazione verso un idioma più modale, una sorta di “medievalismo” (significativo il titolo Lauda) al quale lo aveva avvicinato un’altra figura di riferimento durante i suoi studi: Ildebrando Pizzetti (1880 – 1968).
Direttore del Conservatorio di Milano dal 1924 al 1936, il compositore parmense esercitò una notevole influenza su Farina, soprattutto nell’idea di “sacralità” attribuita alla professione artistica. In un celebre discorso rivolto agli
studenti del Conservatorio di Milano, Pizzetti affermava: «Uno che professi l’arte
senza amarla, senza credere in essa come in un’altissima forma di religione, è
come un prete che dicesse Messa senza credere nel Sacramento dell’Eucaristia».
La necessità di possedere una sorta di “divino dono” per condurre gli studi musicali e intraprendere la professione artistica era sentita anche dallo stesso Ferroni.
Da mio padre appresi che il severissimo maestro esortava gli allievi a domandarsi
tutte le mattine, «prima di dire le orazioni» (sue testuali parole), se «fossero o
non fossero nati per fare il musicista». Un’esortazione che può suonare oggi
“demodée”, ma che non cessa, nel rigore del suo approccio, di conservare una
sostanziale, eterna validità.