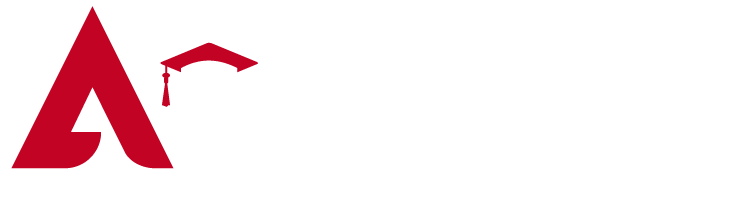La scienza ci aiuta a capire chi siamo, tra DNA, ambiente e tecnologia. La lectio del neuroscienziato Gianvito Martino
Oggi più che mai, parlare di scienza significa parlare di vita. Ma come cambia il nostro modo di vedere noi stessi grazie alle nuove tecnologie? E come si relaziona con il concetto di cyborg, un termine che evoca immagini futuristiche ma che è già vicino a noi? A queste domande prova a rispondere il neuroscienziato Gianvito Martino, direttore scientifico del San Raffaele di Milano, che invita a riflettere su quanto la vita umana sia un intreccio di biologia, ambiente e tecnologia. Lo studioso mercoledì 16 luglio a Rovereto terrà una lectio su questi temi aperta alla cittadinanza, nell’ambito del convegno CogEvo 25
Fino a qualche decennio fa, la scienza vedeva la vita quasi esclusivamente come una serie di eventi chimici e biologici: atomi che si uniscono per formare molecole, e molecole che danno vita al DNA, la grande “macromolecola guida” di ogni organismo. Una visione “riduzionistica”, come si chiama in gergo, che cerca di spiegare ogni fenomeno complesso partendo dalle sue parti più piccole. Ma la realtà si è rivelata molto più sfumata. «Noi non siamo solo “quelli che si guardano allo specchio” e si riconoscono. Siamo soprattutto il risultato di un’interazione continua con un ambiente che non è neutro, ma fondamentale per la nostra evoluzione. Un ambiente che non è fatto solo di radiazioni o sostanze chimiche, ma anche di relazioni sociali, emozioni, cultura», spiega lo studioso.
Come l’ambiente ci modifica
Negli anni Duemila, grazie agli studi sull’epigenetica, si è capito che il DNA, pur rimanendo lo stesso nella struttura, può modificare la sua funzione a seconda delle condizioni esterne, comprese quelle psicosociali. Tradotto: non è solo la genetica a determinarci, ma anche l’ambiente in cui viviamo e interagiamo. Questo porta a un altro concetto chiave che in filosofia è chiamato “emergentismo”.
E che ci ricorda che le proprietà complesse non sono mai solo la somma delle singole parti. Il professore cita un esempio semplice ma efficace: un atomo di idrogeno e uno di ossigeno da soli sono gas, ma insieme formano l’acqua, una sostanza con caratteristiche uniche e fondamentali per la vita. E così è per la mente, che appunto emergendo dal cervello acquisisce caratteristiche e comportamenti che non sono riducibili alla sola materia di cui è composto il cervello, ma diventa qualcosa di più complesso e dinamico, capace di influenzare e modificare anche a livello fisico il nostro corpo.
Cosa è la vita: dal simbionte al cyborg
Per citare il titolo della lectio che il professore terrà a Rovereto, il concetto di cyborg spesso fa pensare a esseri metà umani e metà robot. In realtà, come spiega il neuroscienziato, siamo già “simbionti”. «Il nostro corpo – chiarisce – non è composto solo dalle nostre cellule, ma ospita trilioni di microrganismi, il famoso microbiota, che svolgono migliaia di funzioni metaboliche essenziali per la nostra salute.
In futuro, questi microrganismi potrebbero convivere con dispositivi elettronici integrati nel nostro organismo, creando un vero e proprio ecosistema uomo-macchina». Per essere ancora più esplicativo, torna agli esempi. «Già oggi la tecnologia ci permette di superare limiti fisici: con microchip collegati al cervello una persona tetraplegica può muovere un braccio robotico con il pensiero. Questi progressi sfidano vecchi principi scientifici e filosofici, mostrando che la mente può influenzare la materia in modi che ancora fatichiamo a spiegare completamente». Non solo.
Le scoperte sull’interazione tra ambiente e biologia hanno ricadute pratiche sorprendenti anche in casi di malattie neurodegenerative importanti e che rappresentano oggi una delle grandi sfide della medicina e della società. «Pensiamo alle cosiddette “città dell’Alzheimer” di Amsterdam – dice Martino – progettate per rallentare la degenerazione cognitiva delle persone anziane. Oppure alla tecnologia che aiuta anche in casi di disturbi psichiatrici: pazienti schizofrenici con allucinazioni uditive possono interagire con avatar digitali personalizzati, migliorando sensibilmente la loro qualità di vita. Tutto questo è la dimostrazione di come un ambiente pensato possa diventare terapeutico».
Intelligenza artificiale e responsabilità individuale
La nostra conversazione con il professore si estende all’intelligenza artificiale, sempre più pervasiva e influente sulle nostre vite. Con l’arrivo di quella generativa, come ChatGpt, la nostra capacità di gestire l’informazione si è moltiplicata.
Ma non dobbiamo illuderci, avverte Gianvito Martino: queste macchine sono sì strumenti potenti, ma lavorano solo con i dati che gli diamo. Spesso possono fare errori o essere influenzate da dati imprecisi.
«Non è che le macchine stanno diventando intelligenti come noi – sottolinea, evidenziando un rischio concreto – siamo noi che rischiamo di diventare come le macchine affidandoci troppo a loro e perdendo la nostra capacità di giudizio». La vera sfida è quindi educare, studiare, aggiornare continuamente il nostro intelletto e il nostro senso critico.
Il direttore è convinto che la responsabilità di scelte consapevoli e sane sia ancora nostra. «L’educazione, la prevenzione e la cura del proprio ambiente di vita sono strumenti importanti. Cambiare stile di vita, prendersi cura degli altri e di sé sono pratiche irrinunciabili, senza le quali – conclude – nessuna tecnologia potrà mai risolvere i problemi profondi della nostra società».