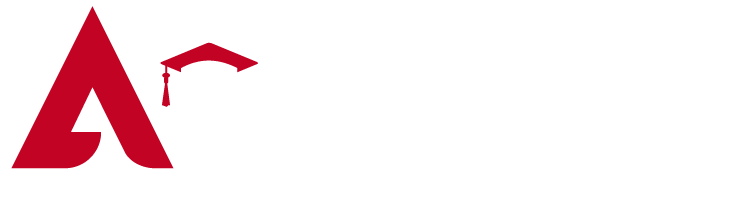Tutto muta, tutto finisce, ma non il mito del confine e il diritto-dovere di innalzare muri per preservare la propria superiorità. Una questione antica che coinvolge il diritto di cittadinanza dei singoli individui
L’indifferenza mostrata qualche giorno fa verso il referendum sulla cittadinanza dimostra non soltanto i limiti dello strumento referendario come istituto di democrazia diretta, ma anche quelli della democrazia stessa, quale forma di governo fondata per definizione sulla sovranità popolare. Se a questa constatazione si aggiungono i recentissimi fatti di Los Angeles (per non parlare di altri scenari), uno sguardo al passato potrebbe forse giovare a comprendere meglio la genesi e forse anche a prevedere l’epilogo di quanto si sta consumando sotto i nostri occhi.
Diamo quasi tutti per scontato che le cartine geografiche abbiano una versione fisica e una politica. I mappamondi che riceviamo in dono da bambini si colorano per far risaltare i confini tra gli stati. Poi da grandi possiamo mostrare ai nostri figli quei mappamondi solo come pezzi di antiquariato, poiché, in una manciata di anni, vecchi imperi si disgregano e altri se ne formano. Viviamo abbastanza per assistere a questo processo, talora graduale, talora rapido e violento.
Abbastanza, ma non troppo per renderci conto che i confini, anche quelli fisici, spariscono e un giorno il suolo su cui poggiamo i piedi sarà dominio dei pesci. Tutto muta, tutto finisce. Ma non il mito del confine, l’idea che gli stati nazionali abbiano una patente di eternità per grazia ricevuta e dunque il diritto-dovere di innalzare muri per preservarne purezza razziale e superiorità civilizzatrice. È un’idea, quest’ultima, molto antica, che coinvolge non solo il problema dei rapporti di forza tra i popoli, ma anche quello del diritto di cittadinanza dei singoli individui.
Nel mondo greco era generalizzata l’idea che i non Greci fossero barbari, estromessi dai diritti di cui godevano i nati in patria. Ma la cultura greca (e latina) produsse anche posizioni in controtendenza, ispirate a modelli più o meno maturi di cosmopolitismo. Essere cittadini del mondo poteva assumere per questi pensatori ‘eterodossi’ diversi significati.
Alcuni si appellavano alla comune costituzione fisiologica degli uomini (tutti respiriamo col naso, tutti abbiamo mani e bocca …). È il caso di Antifonte di Ramnunte, sofista del V secolo a.C., autore di un provocatorio trattato Sulla verità pervenutoci in frammenti grazie ad alcuni papiri di Ossirinco. Egli si scagliava contro chi negava che per natura siamo tutti uguali, barbari e Greci.
Altri invece facevano leva sulla ragione, intesa come unica legge universale cui gli uomini (i sapienti) devono rifarsi. L’universalità di questa cittadinanza, che nelle sue forme più radicali minava alle radici i sovranismi e le convenzioni umane (politiche, sociali e perfino sessuali), fu predicata soprattutto dagli Stoici. Nei papiri di Ercolano leggiamo critiche feroci contro la Repubblica di Zenone di Cizio, una presunta opera giovanile del fondatore della Stoa che per i detrattori sarebbe sfociata addirittura nell’anarchismo!
Ma vi è anche un cosmopolitismo ‘utopistico’. Se ne trova una vaga formulazione ‘laica’ e materialistica in Diogene di Enoanda, epicureo del II secolo d.C., il quale, ormai vecchio, fece incidere un sommario del verbo di Epicuro su una parete del portico di una sua proprietà in Licia, nell’attuale Turchia sud-occidentale. Lo fece per diffondere quanto più possibile il messaggio che la felicità è alla portata di tutti, e qua e là, nell’iscrizione, traspare l’idea (e la speranza) di una fratellanza universale e di una solidarietà umana, la cui realizzazione, in tempi a noi assai più vicini, Giacomo Leopardi avrebbe auspicato nella sua Ginestra.
Ma vi è anche una versione spirituale, cristiana di questa utopia. La si legge in San Paolo, nella Lettera ai Galati: “Non c’è né Giudeo né Greco, né schiavo né libero, né maschio né donna: tutti voi una sola persona in Cristo” (3,28) … Ebbene, oltre un secolo dopo Paolo, nel 212, Caracalla, imperatore romano dal 211 al 217, emanò un editto passato alla storia come Constitutio Antoniniana, che concedeva la cittadinanza a tutti gli abitanti dell’Impero di condizione libera. Non tutti sanno che l’editto è tramandato frammentariamente da un papiro, acquistato nel 1902 a Hermopolis Magna e oggi conservato nell’Oberhessisches Museum di Gießen, in Germania (P.Giss. 40). Non era un provvedimento universale. Il papiro escludeva una categoria difficilmente identificabile (i cosiddetti dediticii), e predisponeva anche severe espulsioni.
Nessuno, insomma, crede che un imperatore corrotto e megalomane come Caracalla, goffo emulo di Alessandro Magno, abbia agito mosso da filantropia. Lo fece per un’esigenza specifica dell’amministrazione imperiale, tanto più che la lotta di classe del tempo non si misurava certo sul terreno della civitas, ma su quello dell’effettivo godimento dei diritti civili, dei quali gli schiavi erano privi da secoli. E proprio l’esistenza della schiavitù nel mondo antico impone cautela in ogni tentativo di contestualizzare provvedimenti antichi vagamente progressisti. Ma lasciamo da parte per un attimo schiavi, plebei e humiliores.
In generale, quando i corifei di un impero, non solo antico, additano nell’estensione della cittadinanza il vero pericolo per le ‘radici’ (addirittura etniche) di una civiltà dimostrano poca lungimiranza. È la negazione dello status di cittadino a chi si sente ormai tale che veicola la rivolta. Se i confini sono solo un errore di prospettiva (lo dimostrano i mappamondi), non lo sono i fenomeni storici che inesorabilmente li stravolgono.
I custodi della pace sociale dovrebbero dunque riflettere e fare in modo che quei mutamenti non si trasformino in bagni di sangue. Il papiro di Gießen, almeno per un po’, scongiurò il pericolo. Lo avrebbe forse evitato del tutto (almeno nelle forme ‘barbare’ praticate da Unni e Visigoti) se il provvedimento che conteneva fosse stato concepito da uno statista illuminato, anziché da un assetato di potere che dominò effimeramente su un impero le cui contraddizioni interne erano già da tempo mature per esplodere e sancire per sempre nuovi confini, e dunque la fine del mondo antico.