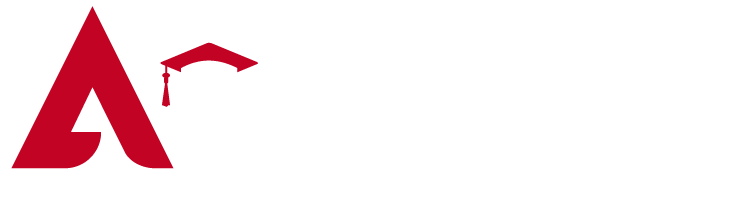Dall’arricchimento dell’uranio al Trattato di non proliferazione nucleare, tutte le questioni sollevate dal dibattito pubblico
Le tensioni internazionali hanno riportato all’attenzione – e non senza preoccupazione – il tema delle armi atomiche e della proliferazione nucleare. Per comprendere tecnicamente i termini della questione, ne discutiamo con Alessandro Ferretti, fisico nucleare del Dipartimento di Fisica dell’Ateneo di Torino.
Cosa si intende per testata nucleare e per bomba atomica?
La bomba atomica è un particolare tipo di testata nucleare: è stata sganciata dagli Usa su Hiroshima e Nagasaki nel 1945 e sfrutta il principio della fissione. I nuclei di alcuni tipi di atomi, come uranio e plutonio, sono molto instabili: basta l’aggiunta di un solo neutrone per frammentarli. Quando si rompono liberano moltissima energia e ulteriori neutroni, che vanno a spezzare i nuclei vicini dando vita a una reazione a catena rapida e distruttiva. Le attuali bombe atomiche arrivano a una potenza equivalente a trecentomila tonnellate di tritolo: se una bomba simile venisse sganciata su Torino causerebbe circa quattrocentomila morti e mezzo milione di feriti. Inoltre, se l’esplosione avviene vicino al suolo, l’energia liberata rende radioattivi gli atomi del terreno e li sparge su un’ampia area, rendendo la zona inabitabile per anni.
L’altro tipo principale di testata nucleare è la bomba all’idrogeno, che sfrutta il principio della fusione. I nuclei di atomi leggeri (come gli isotopi dell’idrogeno), se si trovano a distanze molto ravvicinate, si fondono formando nuclei di elio liberando grandi quantità di energia. Per avvicinare sufficientemente i nuclei bisogna comprimere e scaldare l’idrogeno a temperature intorno ai cento milioni di gradi, e per raggiungerle è necessaria una bomba atomica come innesco. La potenza delle bombe all’idrogeno può superare i cinquanta milioni di tonnellate di tritolo, ma le bombe negli arsenali attuali arrivano “solo” fino a 5 milioni di tonnellate; se lanciate su Torino causerebbero all’istante quasi novecentomila morti e quattrocentomila feriti.
Che processo rappresenta l’arricchimento dell’uranio? A cosa serve e come funziona?
Non tutti i nuclei di uranio sono uguali: ciascuno di essi ha 92 protoni, ma il numero di neutroni può variare. Il 99,3% dell’uranio ha 146 neutroni e viene chiamato Uranio 238, dalla somma di 92 e 146. L’uranio-238 è molto stabile e quindi poco utile per produrre energia o fabbricare bombe. Il restante 0,7% dell’uranio ha invece 235 tra protoni e neutroni, e questo lo rende più instabile e adatto per la fissione. Per far funzionare una centrale nucleare è necessario che la frazione di uranio-235 sia più elevata di quella naturale (tra il 3% e il 5%), mentre per realizzare bombe atomiche bisogna arrivare fino al 90%. L’arricchimento è appunto il processo che aumenta la proporzione di uranio-235.
La difficoltà di separare l’uranio-235 dall’uranio-238 deriva dal fatto che i due isotopi sono chimicamente identici, e quindi non si possono usare reazioni chimiche per distinguerli. Per arricchire l’uranio bisogna quindi sfruttare il fatto che i due nuclei hanno un peso leggermente diverso: innanzitutto si fa reagire l’uranio con il fluoro, ottenendo esafluoruro di uranio che si presenta come un gas. Si immette quindi gas all’interno di speciali centrifughe rotanti: le molecole con l’uranio 238 (più pesante) tenderanno ad accumularsi verso i bordi della centrifuga e quelle con l’uranio-235 si concentreranno di più intorno al centro di rotazione. Il processo avviene a cascata: il gas viene prelevato dal centro della centrifuga, viene messo in un’altra centrifuga e ulteriormente arricchito e così via, fino al raggiungimento della percentuale desiderata. Per arrivare ad arricchimenti molto elevati i tempi sono molto lunghi.
Cosa dice e definisce lo storico Trattato di non proliferazione nucleare (TNP)?
Il TNP, in vigore dal 1970, si propone di limitare la diffusione delle armi nucleari e promuovere il disarmo nucleare. I Paesi che lo sottoscrivono riconoscono il diritto di cinque Paesi (Usa, Russia, Regno Unito, Francia e Cina) di possedere armi nucleari mentre tutti gli altri stati si impegnano a rinunciarvi. In cambio, i cinque Paesi nucleari promettono di avviare negoziazioni “in buona fede” per un disarmo graduale e di garantire l’accesso alla tecnologia nucleare a scopi civili ai paesi che ne facciano richiesta. Per garantire che i Paesi non-nucleari usino la tecnologia solo a scopi civili, i firmatari del trattato accettano che i loro programmi nucleari vengano controllati dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA).
Purtroppo il TNP non prevede tempi e modi stringenti per il disarmo dei paesi nucleari, e quindi non risolve lo squilibrio militare creato dalla deterrenza atomica. Quattro Paesi non hanno sottoscritto il TNP e si sono dotati di armi nucleari: Israele, India, Pakistan e Corea del Nord.
Ci sono segnali di una nuova corsa agli armamenti nucleari?
I recenti attacchi di potenze nucleari contro paesi che hanno aderito al TNP (la Russia nei confronti dell’Ucraina e Israele e Usa nei confronti dell’Iran) fanno temere un’ondata di proliferazione nucleare. Secondo l’AIEA, sia l’Ucraina che l’Iran stavano rispettando il TNP e gli attacchi da loro subiti dimostrano che aderire al TNP non garantisce protezione contro gli attacchi da parte di potenze nucleari. Inoltre, appare probabile che se l’Ucraina o l’Iran avessero posseduto armi nucleari, i Paesi attaccanti ci avrebbero pensato più volte prima di intraprendere delle aggressioni militari, per timore di una ritorsione. Si sono quindi create le condizioni politiche per cui la stessa logica che ha spinto la Corea del Nord a ritirarsi dal TNP per dotarsi di testate nucleari possa essere seguita da altri Stati.
E, invece, di cosa parliamo quando parliamo di energia nucleare?
Le bombe atomiche esplodono a causa della reazione a catena incontrollata: ogni atomo, quando si fissiona, libera 2-3 neutroni che vanno a fissionare altri nuclei. Ogni fissione secondaria libera ulteriori 2-3 neutroni e quindi il numero di atomi fissionati aumenta in maniera esponenziale dando luogo ad un’esplosione.
Le centrali nucleari sono dotate di dispositivi che assorbono una parte dei neutroni emessi dalla fissione, in modo che ogni fissione generi un solo neutrone. In questo modo il processo di rilascio dell’energia atomica non è più esponenziale ma stabile e graduale, e quindi può essere sfruttato per la produzione di energia elettrica in modo analogo alle centrali termiche.
Il vantaggio principale delle centrali nucleari è che il combustibile nucleare non emette anidride carbonica o altri gas serra, e che il costo di tale combustibile è competitivo rispetto ai combustibili fossili. Il problema principale è naturalmente quello del rischio di incidenti catastrofici, come quelli verificatisi a Cernobyl e a Fukushima. Per scongiurare tali rischi, gli standard di sicurezza delle centrali devono essere estremamente elevati e questo fa lievitare moltissimo tempi e costi della loro costruzione.
Inoltre, le centrali nucleari producono abbondanti scorie radioattive a lunghissima vita, che richiedono per lo smaltimento costosi e rischiosi riprocessamenti e la creazione di depositi di stoccaggio a lungo termine, rendendo fondamentalmente antieconomici nuovi investimenti in grandi centrali. Ciò non significa che si debba abbandonare la ricerca in questo campo, anzi. La speranza è che la ricerca riesca a trovare nuovi modi di liberare energia dai nuclei che siano intrinsecamente immuni da rischi catastrofici, privi di scorie e rischi ambientali e, naturalmente, economicamente competitivi.