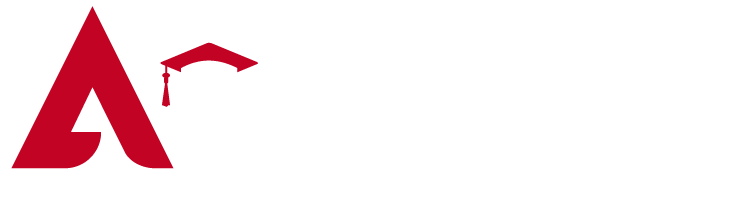Il 28 maggio scorso, intorno alle ore 15.30, un evento catastrofico ha colpito la Valle della Lötschental, nelle Alpi svizzere. Un’enorme valanga di ghiaccio e roccia si è sviluppata sul versante settentrionale del Kleines Nesthorn (una montagna di 3.342 metri sopra il villaggio di Blatten) coinvolgendo il Ghiacciaio di Birch e si è riversata sul fondovalle. La Valle della Lötschental è situata all’interno del Massiccio dell’Aar-Gottardo, caratterizzato essenzialmente da graniti e rocce metamorfiche, che si presentano foliate e fratturate.
La massa di detriti, stimata in circa 9 milioni di metri cubi (6 milioni di metri cubi di roccia e 3 di ghiaccio, secondo Raphaël Mayoraz, responsabile del Servizio per i pericoli naturali del Cantone Vallese), è precipitata per oltre due chilometri lungo il fianco della montagna, è risalita per oltre 200 m di altezza sul versante opposto della valle, e ha proseguito la sua corsa sul fondovalle per altri due chilometri circa. L’impatto è stato devastante: il villaggio di Blatten (300 abitanti, a circa 1540 metri di altitudine) è stato sepolto e distrutto per il 90% sotto una coltre di ghiaccio, detriti e neve che in alcuni punti ha superato i 100 m di spessore, e il torrente Lonza che scorre sul fondovalle è stato sbarrato dall’accumulo e ha formato un lago.
Fortunatamente, grazie al monitoraggio costante della montagna nei giorni precedenti e all’evacuazione tempestiva degli abitanti, il disastro non ha causato una strage: al momento si segnala solo una persona dispersa. Infatti, il gigantesco crollo del 28 maggio è stato preceduto da una serie di segnali premonitori. Fin dalla fine degli anni 1990 il ghiacciaio era sotto osservazione a seguito di valanghe di ghiaccio che avevano parzialmente interessato le infrastrutture della valle.
Da anni, poi, il lato settentrionale del Kleines Nesthorn era soggetto a piccoli crolli e frane minori, che nel tempo hanno formato una copertura detritica continua sulla parte terminale del ghiacciaio, che sin dal 2019 ha evidenziato un’avanzata anomala nel contesto di ritiro glaciale generalizzato, dovuta presumibilmente a un aumento della velocità di flusso piuttosto che a condizioni favorevoli al ghiacciaio. A partire da metà maggio 2025 la situazione ha iniziato a evolvere rapidamente. Tra il 19 e il 20 maggio un intero settore della parete rocciosa instabile si è messo in movimento in profondità.
In poche ore la cresta della montagna ha ceduto e si è abbassata di quasi 100 metri: diverse centinaia di migliaia di metri cubi di roccia si sono riversati sul sottostante Ghiacciaio di Birch, un piccolo ghiacciaio sospeso con la fronte a 2600 metri di altitudine, aggiungendosi all’ingente volume di detriti (stimato in oltre 1 milione di metri cubi) accumulatisi in precedenza. Sul fianco innevato della montagna è apparsa una vasta cicatrice marrone nel punto da cui la massa rocciosa si è staccata.
Dopo questo grande crollo di roccia, l’attenzione si è spostata dal versante roccioso al sottostante Ghiacciaio di Birch. Il ghiacciaio, caricato dall’enorme massa di rocce cadute, ha cominciato a scivolare verso valle molto più velocemente del solito: nei giorni successivi, la fronte del ghiacciaio si è mossa a una velocità eccezionale, superando i 10 metri al giorno. Mentre i movimenti lungo il versante roccioso apparivano essersi temporaneamente stabilizzati dopo il 20 maggio, il ghiacciaio diventava sempre più instabile. Il 28 maggio, infine, il collasso improvviso del ghiacciaio (non si sa se innescato da ulteriori crolli di roccia, o semplicemente dal raggiungimento di un equilibrio limite) ha generato la gigantesca valanga che ha investito Blatten.
I dati a disposizione e gli esempi di altri fenomeni simili avvenuti sulle Alpi Europee e in altre catene montuose suggeriscono che diverse cause, legate soprattutto al riscaldamento climatico, abbiano contribuito a questo disastro. Il versante settentrionale del Kleines Nesthorn si trova in condizioni di permafrost (terreno perennemente ghiacciato) e, fino ad alcuni decenni fa, era in gran parte ricoperto da ghiaccio. Il riscaldamento climatico, in alta montagna, causa il ritiro dei ghiacciai e lo scongelamento del permafrost.
Quando il ghiaccio che riveste le pareti e quello che permea le fratture della roccia si fonde, i versanti intrinsecamente instabili in virtù delle loro caratteristiche geologiche, sottoposti a decompressione e privi della coesione fornita dal ghiaccio, possono rapidamente destabilizzarsi. L’acqua di fusione del ghiaccio, insieme alle piogge sempre più frequenti in quota, può infiltrarsi in profondità nelle fessure della montagna e accelerare la destabilizzazione dei versanti: se un pendio roccioso instabile incombe su un ghiacciaio, i crolli di roccia possono dare avvio a pericolose catene di processi dall’esito imprevedibile, come accaduto in questo caso.
L’esempio di un fenomeno in crescita
La rarità di questi eventi e l’assenza di una loro documentazione sistematica rendono difficile stabilire con certezza l’esistenza di un trend di aumento della loro frequenza di accadimento. Tuttavia, l’evento che ha colpito il Ghiacciaio di Birch presenta tutti gli ingredienti per essere considerato una conseguenza dei cambiamenti ambientali in atto per effetto del riscaldamento climatico in corso. In particolare, la parete rocciosa dove si sono sviluppati i crolli ha subìto negli ultimi decenni una deglaciazione e presumibilmente una degradazione del permafrost (la quota – 3300 m e l’esposizione del versante – N sono tra le più favorevoli allo sviluppo di instabilità per effetto della degradazione del permafrost), nonché una perdita di sostegno al piede per effetto dell’abbassamento del Ghiacciaio di Birch.
In aggiunta, il settore frontale del ghiacciaio si trovava in condizioni temperate e dunque ha potuto facilmente fornire acqua di fusione. La grande quantità di acqua coinvolta nel movimento sembra comprovata dalla notevolissima mobilità del flusso di ghiaccio, detriti e neve. La mobilità di un fenomeno di questo genere è descritta in modo semplice dal rapporto tra il dislivello coperto (H) e la distanza orizzontale percorsa (L) dalla valanga. In questo caso, il dislivello è stato pari a circa 1400 m, e la distanza orizzontale percorsa è stata di circa 4000 m: questi dati corrispondono a un valore di mobilità pari a circa 0,30, ovvero una mobilità estremamente elevata (uno studio condotto su valanghe di ghiaccio occorse nelle Alpi Italiane ha evidenziato valori di H/L compresi tra 0,80 e 0,33).
Eventi di questo tipo, con il coinvolgimento combinato di una grande frana rocciosa e del collasso di un ghiacciaio, sono rari ma sembrano in aumento negli ultimi decenni sulle Alpi. La successione di grandi crolli in alta montagna sta diventando preoccupante. Basti ricordare il crollo di Punta Thurwieser (massiccio Ortles-Cevedale) nel 2004, quello del Pizzo Cengalo (Alpi della Bregaglia) nel 2017, e più di recente il collasso di una parte del Piz Scerscen (massiccio del Bernina) nell’aprile 2024. Questi esempi mostrano come fenomeni simili stiano accadendo con maggiore frequenza. Tuttavia, il disastro di Blatten spicca per le sue conseguenze: raramente un evento del genere aveva distrutto così gran parte di un centro abitato. L’insieme di un’enorme frana più il crollo di un intero settore glaciale ha prodotto un impatto eccezionale, forse il peggiore mai registrato in tempi recenti in Svizzera.
L’importanza della previsione
In eventi di questo genere la previsione è fondamentale. Dopo aver riconosciuto i segni premonitori dell’instabilità, occorre attivare servizi di monitoraggio con tempi di rivisitazione giornalieri e con risoluzioni geometriche elevate. In questi casi i dati geospaziali di osservazione della Terra, da satellite o da aereo, come le immagini ottiche multispettrali possono aiutare a monitorare gli spostamenti superficiali e stimare il grado di pericolosità. In fase di post-evento le stesse immagini permettono di classificare la tipologia di roccia esposta, visualizzare eventuali tracce d’acqua e monitorare gli eventuali bacini lacustri che si possono formare come nel caso di Blatten.
Ora l’attenzione è rivolta al lago che si è formato dietro la diga naturale di detriti sul torrente Lonza. Il livello del lago sembra stabilizzato, tuttavia permane il rischio (anche in associazione a eventuali condizioni meteo avverse) che la diga di detriti ceda all’improvviso oppure che l’acqua tracimi repentinamente, causando un’ondata improvvisa a valle. Le autorità svizzere stanno monitorando la situazione ora per ora e hanno già evacuato per precauzione alcune case nei villaggi più a valle. Si stanno anche pianificando interventi per scaricare l’acqua in modo controllato dal lago artificiale, così da scongiurare un possibile secondo disastro nelle comunità a valle. In definitiva, il caso di Blatten dimostra come la fusione dei ghiacciai e l’instabilità dei versanti montuosi possano portare a effetti catastrofici, e mette in evidenza la necessità di vigilare attentamente su questi rischi nell’ambiente alpino.
Questo evento ha mostrato come un costante monitoraggio dei ghiacciai – pur non potendo impedire i cambiamenti in atto nelle nostre montagne dovuti al riscaldamento globale – permette di prevenire e limitare gli impatti di questi fenomeni. La conoscenza dettagliata del territorio insieme alla prevenzione e al monitoraggio dei fenomeni franosi, uniti al massimo sforzo per diminuire le immissioni di C02 di origine antropica nell’atmosfera, sono essenziali per affrontare in modo razionale le sfide climatiche.
*Gli autori sono: Rodolfo Carosi (docente del Dipartimento di Scienze della Terra di UniTo e presidente della Società Geologica Italiana), Marta Chiarle, (Ricercatrice CNR-IRPI, referente campagne glaciologiche annuali Comitato Glacioligico Italiano CGI), Marco Giardino (docente del Dipartimento di Scienze della Terra, Vicepresidente CGI) Walter Maggi (Presidente del CGI e Fondazione CGI), Luigi Perotti (docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari Unito, segretario generale CGI).