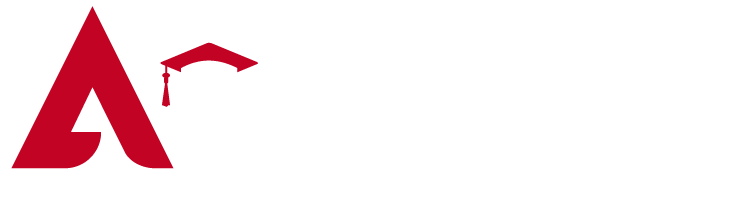Il recente cambiamento dello scenario internazionale ridisegna il tema della sicurezza nazionale. Abbiamo interpellato Luciano Bozzo, docente di Relazioni internazionali e Studi strategici alla Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, per capire, al di là delle decisioni geo-politiche, come il mutato panorama influenzi la formazione accademica e professionale di coloro che si interessano a questi temi.
Come cambia il quadro della sicurezza nazionale nell’attuale contesto mondiale, sconvolto da guerre che coinvolgono interi popoli, dalla crisi di alleanze e prassi consolidate, da una conflittualità che sembra non risparmiare alcun ambito della vita sociale?
Negli anni oramai lontani della guerra fredda assicurare la sicurezza nazionale significava, in larga misura, far fronte a una minaccia specifica, esterna allo Stato, di natura militare tradizionale. Era chiaro da dov’è quella minaccia potesse provenire, chi e come avrebbe dovuto affrontarla. Il sistema internazionale era semplice: due superpotenze, due blocchi di alleati a fianco dell’una e dell’altra, poderosi apparati militari, convenzionali e nucleari contrapposti, a garanzia dell’equilibrio del sistema.
Finita quella stagione si aprì la fase dei “dividendi della pace”, ovvero della distensione internazionale, della riduzione delle forze e spese militari, della fine dell’incubo di una guerra termonucleare tra le superpotenze e i blocchi. L’insorgere del fenomeno terroristico internazionale pose fine all’illusione di un nuovo ordine internazionale pacifico, di matrice liberal-democratica. I Paesi occidentali, dunque anche il nostro, poterono comunque illudersi che oramai il fenomeno bellico riguardasse aree periferiche nello scenario internazionale, che fosse superata la lunga età delle guerre tra Stati. Anche questa fase è tuttavia terminata.
Non solo è tornata nel cuore dell’Europa una guerra tra Stati combattuta da centinaia di migliaia di uomini, con tecnologie vecchie e nuovissime, ma al suo fianco si è sviluppata ogni forma di “guerra ibrida”. Le guerre del futuro potranno esserci imposte, non saranno più “scelte”, così come potranno essere imposti mezzi d modi del confronto. La guerra non si combatte più (solo) sul campo di battaglia con mezzi convenzionali. Si combatte, oltre che, a volte, ancora in cielo, terra e mare, anche nel dominio cibernetico, in quello spaziale, nei media vecchi e nuovi, nelle alte corti internazionali e nei consessi internazionali, con i mezzi più diversi – militari e non – e nella piena interazione tra questi diversi spazi, fisici e virtuali. Combattono gli uomini e oramai combattono i robot, a iniziare da quelli volanti (i droni). È evidente che tutto questo è molto altro ancora impone di ripensare il concetto stesso di sicurezza e difesa nazionale, nel nostro come in qualsiasi altro Paese vicino e alleato.
In questa fase caratterizzata dalla “guerra ibrida”, cos’altro emerge dai suoi studi circa il ricorso massiccio a tecnologie avanzate?
Le due guerre in atto in questo momento, o meglio, le due guerre che più attraggono l’attenzione dei media e delle opinioni pubbliche occidentali, a Gaza e in Ucraina, dimostrano in maniera chiara alcuni profondi mutamenti già intervenuti sui campi di battaglia. Ho già fatto riferimento alla robotica, ma dobbiamo aggiungere l’impiego dell’intelligenza artificiale, di nuovi sistemi d’arma, l’uso dei satelliti, di tecniche di guerra psicologica e cognitiva, di attacchi cibernetici e di operazioni sofisticate di intelligence. L’uomo progressivamente perde l’esercizio e perfino la possibilità di controllo dei mezzi militari. L’impiego bellico di sciami di droni tramite intelligenza artificiale è un dato di fatto, così come la selezione, sempre tramite IA, della massa di informazioni raccolte con i più diversi sistemi d’ascolto e rilevazione dati, al fine della scelta degli obiettivi da colpire e distruggere. Il futuro è già qui, a poca distanza da noi. Due terzi delle perdite stimate nei tre anni e passa di guerra in Ucraina sono dovute all’impiego di droni, ovvero robot volanti. Evidentemente questo cambia la natura della guerra: chi la combatte, con quali mezzi e in che maniera. Questo cambia, di conseguenza, il concetto stesso di sicurezza e difesa nazionali. Non si tratta più di proteggere il Paese da minacce militari tradizionali di chiara provenienza. Le minacce possono essere della più diversa natura e provenienza, molto spesso, anzi, non evidenti, subdole, nascoste e di provenienza sconosciuta o non facilmente definibile. E allora: da chi e come difendersi?
In che modo questi cambiamenti interrogano il mondo della formazione di chi è chiamato ad operare per la sicurezza nazionale? Che esigenze devono trovare risposta nei percorsi che sviluppano nuove professionalità in questi ambiti?
Occorre sviluppare una cultura in materia e preparare il personale che nei campi più diversi, civili e militari, in ogni ruolo e a qualsiasi livello di responsabilità dovrà, domani, garantire la sicurezza del Paese. L’Università di Firenze ha dato vita già da parecchi anni ad alcuni di questi corsi e percorsi formativi. Vorrei ricordare il master di secondo livello in Leadership e analisi strategica, giunto alla sedicesima edizione, e ancor più il corso di perfezionamento post-laurea in Intelligence e sicurezza nazionale, giunto all’undicesima edizione. Quest’ultimo percorso di alta formazione interdisciplinare è centrato sui temi di cui abbiamo parlato. Al momento e fino al prossimo 19 settembre sono ancora aperte le iscrizioni, a tutti coloro che siano in possesso di una laurea triennale di qualsiasi genere, conseguita in un Ateneo nazionale o all’estero e di riconosciuta validità in Italia.
Articolo proveniente da ‘UnifiMagazine’, magazine universitario dell’università di Firenze